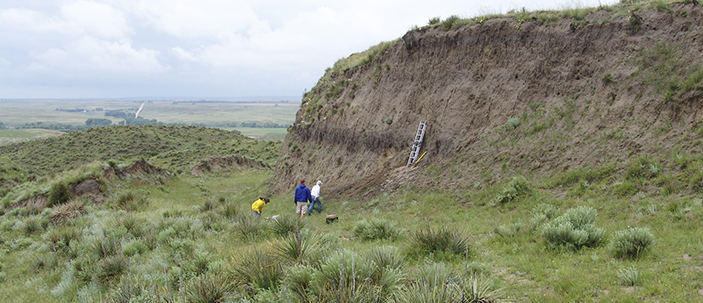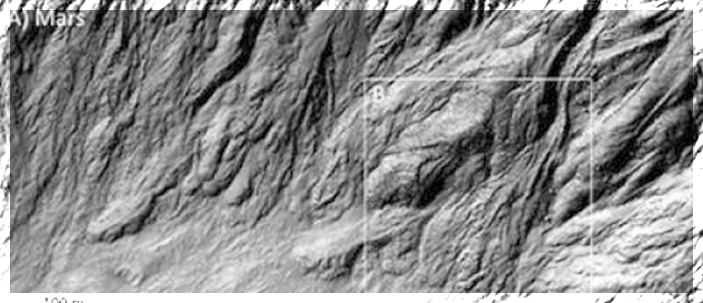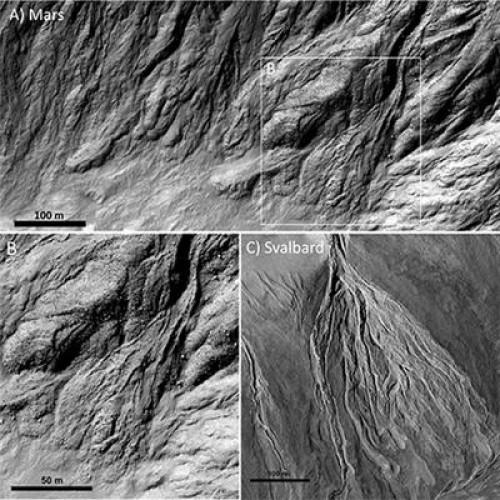Con la definizione di Territori del Nord-Ovest viene indicata la vastissima regione del Canada settentrionale che su una superficie di più di 1 milione di Km quadrati ospita una popolazione di poco più di 41.000 abitanti.
Dal punto di vista geografico e climatico è tra le aree più fredde e inospitali della Terra; ma dal punto di vista geologico è una regione molto interessante, perchè è considerata la porzione più antica della crosta terrestre, un brandello della primigenia pellicola che si andava formando nel corso del raffreddamento dell’oceano di lava che avvolgeva la Terra.
L’affioramento più antico delle rocce che costituiscono quest’area è stato stimato di un’età di 4,2 miliardi di anni. Si tratta di una roccia particolare, uno gneiss chiamato dai geologi ‘gneiss di Acasta’, dal nome del vicino fiume, che scorre a 300 chilometri a nord di Yellowknife, la città capoluogo della regione.

Gli gneiss sono rocce ricche di quarzo e feldspati, che si formano sotto forti pressioni, quindi a notevole profondità, soprattutto nella zona di convergenza di due placche.
Jesse Reimink, un ricercatore dell’Università di Alberta, che ha studiato per tre anni campioni di queste rocce, riferendosi alla loro formazione e al rapporto con la formazione della crosta, così scrive in uno studio su Nature Geoscience.:
“La tempistica e le modalità di formazione della crosta continentale nel corso della storia della Terra è un argomento controverso”, e prende come esempio l’Islanda quale valido paragone per il modo di formazione dei primi continenti.
I continenti attuali si sono formati durante gli spostamenti delle placche tettoniche, quando una placca si incunea sotto l’altra nel mantello, causando una risalita di magma in superficie, nel processo che va sotto il termine di subduzione.
“Non è chiaro se la tettonica a zolle si verificava anche tra i 2,5 e i 4 miliardi di anni fa oppure se era in gioco qualche altro processo”, afferma Reimink.
Secondo la teoria che va per la maggiore, il primo continente ebbe origine dall’oceano di lava che avvolgeva il pianeta, allorché il magma in risalita dal mantello cominciò a raffreddarsi e a solidificarsi nella crosta primigenia.
L’Islanda si formò quando il magma risalì dalle profondità a livelli superficiali, inglobando rocce vulcaniche già formatesi precedentemente. Per questo, Reimink considera l’Islanda un riferimento teorico sulla formazione della primitiva crosta continentale della Terra.
Esaminando le rocce del complesso di Acasta Gneiss, attribuite – come detto – a circa 4 miliardi di anni fa, è stato possibile osservare i numerosi eventi metamorfici cui sono state sottoposte, senza però riuscire a comprendere appieno la geochimica della formazione.
Fortunatamente, però, alcune rocce, definite dal team di ricerca ‘Idiwhaa’ ossia ‘antiche’ nel dialetto Tlicho locale, sono state meglio conservate e hanno quindi consentito di capire meglio le fasi attraversate e le caratteristiche geochimiche.
Reimink ha trovato che i processi di formazione di queste rocce sono molto simili a quelli dell’Islanda attuale.
“Questa è una prova che un ambiente simile all’Islanda così come la vediamo oggi è stato presente sulla Terra primordiale”, osserva. “Queste rocce sono tra i più antichi campioni di crosta protocontinentale che abbiamo e potrebbero aver contribuito a favorire la formazione della crosta continentale”.
Leonardo Debbia
3 giugno 2014