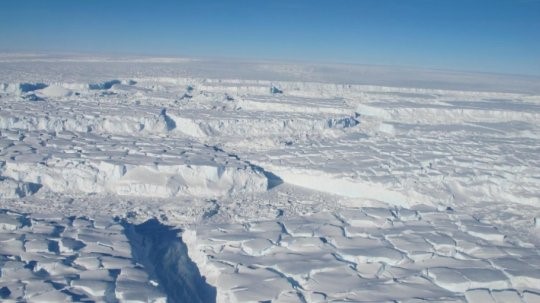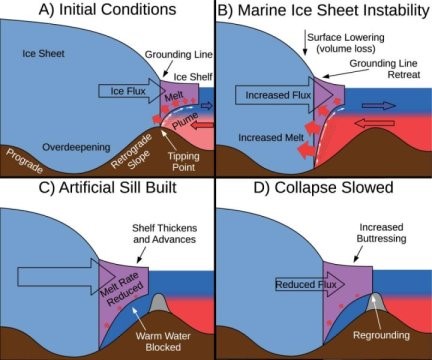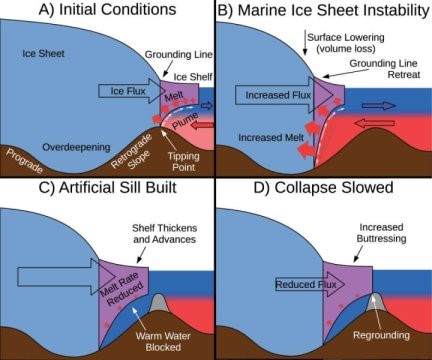Fino ad oggi, i Neanderthal sono stati quasi sempre raffigurati con colonne vertebrali dritte e una postura scorretta o, quanto meno, ben diversa dalla nostra.
Tuttavia, questi esseri umani preistorici probabilmente erano più simili a noi di quanto sia stato finora ritenuto.
Alcuni ricercatori dell’Università di Zurigo hanno dimostrato che i Neanderthal avevano un’andatura eretta proprio come gli esseri umani moderni (Homo sapiens) e a questa constatazione si è arrivati grazie alla ricostruzione virtuale di un bacino e della colonna vertebrale di uno scheletro di un Neanderthal molto ben conservato.

Una postura eretta e ben bilanciata è, di fatto, una delle caratteristiche principali di Homo sapiens, mentre Homo neanderthalensis, ancora agli inizi del XX secolo, veniva descritto come un individuo che avesse mantenuto la posizione eretta solo parzialmente.
Queste ricostruzioni si basavano esclusivamente sullo scheletro di un Neanderthal maschio anziano rinvenuto nel sito di La Chapelle-aux-Saints, in Francia.
Solo negli anni ’50 gli studiosi appurarono che l’immagine del Neanderthal come uomo delle caverne curvo, quasi gobbo, non fosse più attendibile.
Ovviamente, fu necessaria tutta una serie di rinvenimenti fossili per poter raggiungere questa convinzione.
La somiglianza con gli esseri umani moderni, sia in terminin evolutivi che comportamentali, oggi sono note, e tuttavia, in questi ultimi anni, il vecchio modello è stato riproposto.
A far sorgere nuovi dubbi erano stati dei recenti studi condotti su alcune vertebre isolate che avevano fatto concludere che i Neanderthal non potevano avere una colonna vertebrale a forma di doppia S ben sviluppata.
Tuttavia, una ricostruzione virtuale dello scheletro di La Chapelle-aux-Saints – lo stesso su cui ci si era espressi una prima volta – ha ora fornito prove di quanto fosse sbagliata la vecchia idea.
Il modello anatomico del nuovo studio è stato ricostruito da un gruppo di ricerca guidato da Martin Haeusler, biologo e antropologo dell’Università di Zurigo, cui si è affiancato Erik Trinkaus, paleoantropologo della Washington University di St. Louis (USA).
Il team è stato in grado di dimostrare che sia l’individuo in esame che altri Neanderthal avevano una regione lombare curva, come pure il collo, proprio come gli esseri umani attuali.
A questa conclusione gli studiosi sono giunti mentre ricostruivano il bacino.
Mettendo insieme le singole vertebre lombari e cervicali, si è giunti a ricomporre la curvatura della colonna in maniera più pronunciata. Il contatto molto stretto tra i processi spinosi della colonna – apparsi come proiezioni ossee sul retro di ogni vertebra – è divenuto chiaro, così come i segni di usura, in parte causati dalla curvatura della colonna vertebrale.
Anche i segni di usura nell’articolazione dell’anca indicavano una postura eretta, simile a quella degli uomini moderni.
“La sollecitazione sull’articolazione dell’anca e la posizione del bacino non sono affatto diverse dalle nostre”, afferma Haeusler. E questo risultato è testimoniato anche dalle analisi di altri scheletri di Uomini di Neanderthal di cui si avevano resti di vertebre e ossa pelviche in numero sufficiente.
“Nel complesso, non ci sono prove che i Neanderthal avessero un’anatomia fondamentalmente diversa dalla nostra”, spiega Haeusler. “Chiarito questo punto, ora è il momento di riconoscere le somiglianze di base tra i Neanderthal e i Sapiens e di spostare l’attenzione sui sottili cambiamenti biologici e comportamentali che si sono verificati negli esseri umani del tardo Pleistocene”.