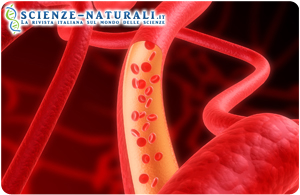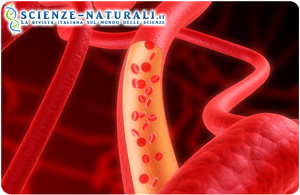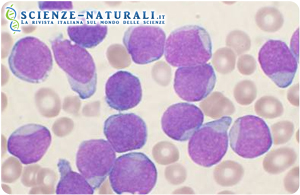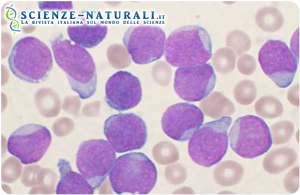I ricercatori dell’Istituto Gaslini di Genova, grazie alla collaborazione con l’Università di Verona, hanno sperimentato un nuovo test che permetterebbe di capire se una persona potrà essere affetta, in futuro, da celiachia, la malattia infiammatoria cronica dell’intestino tenue che porta ad essere intolleranti al glutine.
I ricercatori dell’Istituto Gaslini di Genova, grazie alla collaborazione con l’Università di Verona, hanno sperimentato un nuovo test che permetterebbe di capire se una persona potrà essere affetta, in futuro, da celiachia, la malattia infiammatoria cronica dell’intestino tenue che porta ad essere intolleranti al glutine.
L’esame in questione si basa sulle classiche analisi del sangue, per analizzare la presenza degli anticorpi contro la proteina VP7 del rotavirus, il microbo in grado di generare la patologia.
Questo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Immunologic Research, ha tenuto sotto controllo per anni oltre 300 bambini geneticamente disposti alla celiachia, di cui il 10%, nel corso del follow up, ha sviluppato la mattia. Durante la ricerca, è stato possibile scoprire che nei bambini, gli anticorpi in questione possono comparire anche ben 10 anni prima.
Il professor Antonio Puccetti, che ha preso parte al test, ha spiegato: “Con una semplice analisi del sangue è oggi possibile prevedere l’insorgenza della malattia celiaca nei soggetti geneticamente predisposti con largo anticipo rispetto ai test diagnostici convenzionali”.
E Lorenzo Moretta, direttore scientifico del Gaslini, ha aggiunto: “La diagnosi di celiachia oggi disponibile si basa sulla presenza nel sangue di particolari anticorpi diretti contro un enzima (Transglutaminasi) che agisce sul glutine, e su una biopsia eseguita con gastroscopia. Il nostro studio rappresenta quindi un importante passo avanti per una diagnosi precoce di celiachia e può essere particolarmente utile in caso di celiachia con sintomatologia atipica extraintestinale o nei casi di celiachia silente. Ricordiamo che la celiachia è una patologia subdola, che può portare danni notevoli ad un organismo in accrescimento, pertanto una diagnosi precoce è di particolare rilevanza”.
Davide Basili
18 maggio 2013